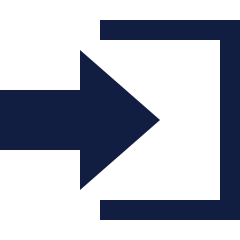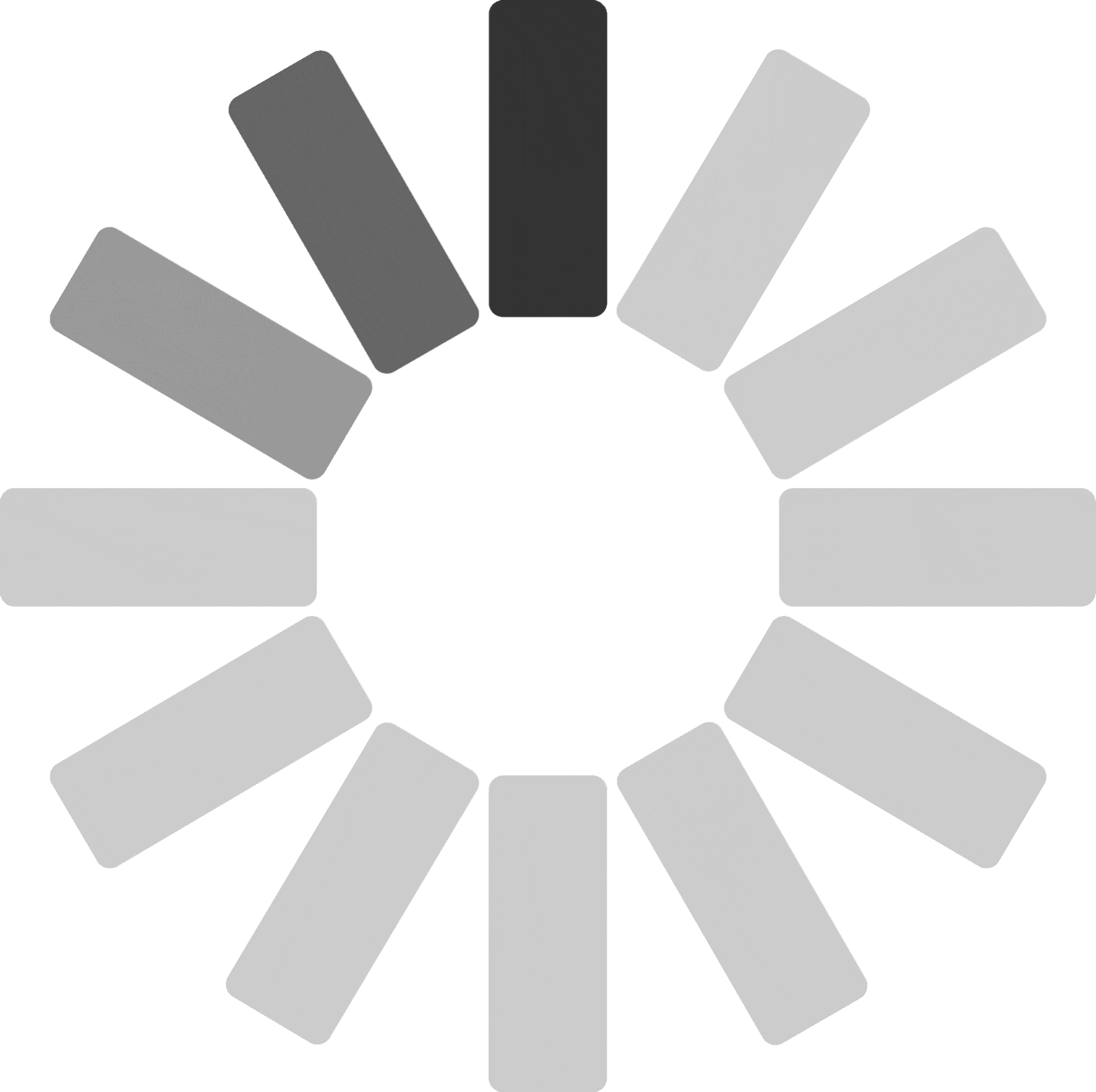La tempesta che si portò via le auto della Regina infuriò per quindici anni e fu una delle più tremende. A mezzo secolo di distanza, mentre ricordiamo le ultime vetture iconiche, le fusioni impossibili, gli errori tattici e l’invecchiamento dei modelli sono diventati un caso da manuale.
Qualche mese fa, presentando la mostra sulla Lancia Aurelia al Museo Nazionale di Torino, scoppiò una tempesta in un bicchier d’acqua. Uno dei relatori ebbe il coraggio di affermare, non senza rimpianti, che il marchio che firmava la mirabile vettura di settant’anni fa oggi non esiste più. Al tavolo di conferenza ci fu un mezzo urlo di dolore: chi si affrettava a sottolineare i fasti della Lancia Ypsilon, chi si sbilanciava a profetizzare augusti ritorni, chi investimenti a sorpresa, già pronti nelle casse del gigante buono FCA. Bene, in attesa che tutto questo avvenga, non resta che contare i modelli in listino oggi tra i brand del Gruppo e provare a sfogliare un Quattroruote di quando eravamo ragazzi.
L’impero è crollato. Ma nella lunga storia dell’automobile c’è qualcuno che ha fatto di meglio. E’ riuscito, nel giro di una quindicina d’anni, a far evaporare tutta l’industria di un paese. Ad affrontare di poppa la tempesta strategica degli anni ’70, a sbagliare l’onda e fare un naufragio da manuale. E’ il caso delle fabbriche inglesi, che negli anni ’60 contavano una quindicina di marchi, con cinque costruttori (inclusa Ford UK) che coprivano il 90% della produzione. Sulle isole britanniche soffiava il vento dell’autarchia e anche nell’ex-impero si produceva su licenza e si compravano le auto di Sua Maestà. Chi c’era ben ricorda nomi come Triumph, Hillman, Sunbeam, Morris, Austin, Vauxall, Riley, Wolseleysolo per citare i maggiori. Una generazione dopo erano tutti scomparsi e oggi nessun neopatentato ne ha mai sentito parlare. Capitolo a parte, non meno imbarazzante, fu la sorte degli dei dell’Olimpo, Rolls Royce, Bentley, Jaguar e Land Rover, che come noto sono sopravvissuti, ma con iniezioni di denaro e management che vengono da molto lontano.
I fattori determinanti. Non è un temporale da poco. L’auto inglese ha fatto la storia nello sport, nel lusso, ma anche nel marketing e nel commercio, basti pensare al successo delle piccole spider britanniche in America negli anni ‘50, o della Land Rover costruita con i kit da assemblare in mezzo mondo, o, ancora, di prodotti “neo-globali” in categorie diversissime, dalla Mini alla Jaguar E-type. Sono le auto divenute bandiera del made in England e di un certo, invidiabile stile e non è un caso se il collezionismo d’oltremanica è, ancora oggi, un fenomeno unico. Ma come è potuto succedere un tale disastro? I fattori in gioco sono stati diversi e complessi. Valgono una approfondita lettura dei volumi che li narrano o, almeno, una visita al British Motor Museum di Gaydon, che non si vergogna di metterli in mostra. Almeno tre ragioni furono di portata devastante: il passaggio di mano, a favore dell’americana Chrysler, di un protagonista come il Gruppo Rootes, e il suo progressivo decadimento. La fusione di molti altri nel pastone British Leyland e, non ultimo, l’invecchiamento dell’auto inglese in generale, a fronte di una concorrenza europea e giapponese più moderna e aggressiva.
Cattedrali nel deserto. L’agonia della Rootes, coincise, alla metà degli anni ’60, con un cambio generazionale e, soprattutto, con l’insuccesso della Hillman Imp. Quella che avrebbe dovuto essere la risposta alla Mini della BMC fu un fiasco che privò la Rootes delle risorse per progettare futuri modelli. Per la Imp si verificò una specie di “caso Alfasud” in salsa inglese, con uno stabilimento costruito in un’area depressa, senza competenze, e con problemi logistici pesanti. Questo, unito ad un picco di agitazioni sindacali, portò a una qualità di prodotto scadente e alla perdita di credibilità del marchio. Quando, nel 1967, il gruppo finì, insieme alla Simca francese, nella divisione europea della Chrysler si pensò ad una grande occasione, che però si manifestò una sola volta in un decennio, con la nascita della Horizon. Quasi tutto il resto, dal tentativo di importare auto inglesi negli USA, ad una serie di modelli poco centrati, andò nella direzione opposta.
Fine di un’epoca. Le sfortunate vicende della British Leyland sono più note e divenute sinonimo di fusioni impossibili. Nel 1968, con i favori del governo laburista Wilson, si operò il merging tra un gruppo in buona salute, come la Leyland Motor Corporation, e uno azzoppato come la BMH (BMC, Pressed Steel, Jaguar). A giochi fatti si scoprì che la BMH, che era grande il doppio ma aveva prodotti datati, non aveva un solo progetto nuovo nei cassetti. Quelli che furono faticosamente messi insieme, come la Morris Marina, riuscirono a vendere bene nel mercato interno, ma non reggevano il confronto internazionale e con quello che Ford e GM facevano in altre parti del Regno Unito. Altrettanto importante fu la pletora di modelli – spesso in diretta concorrenza – che convivano nel colosso BL, che al suo picco contava sessanta stabilimenti sparsi per il Paese. La grande ristrutturazione degli anni ’70 (quasi una nazionalizzazione), portò ad altre scelte forzate, spesso illogiche, che i manager ancora in vita ricordano oggi, quando hanno occasione di parlarne, come autentici psicodrammi. Ci furono automobili di successo, come la Rover SD1 del 1977 o, agli antipodi, la Mini Metro del ’80. Ma erano gli ultimi fuochi, che nei favolosi anni ’80 si sarebbero di fatto estinti, insieme a una storia gloriosa e a un fascino d’altri tempi.