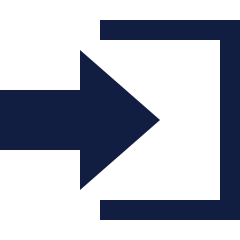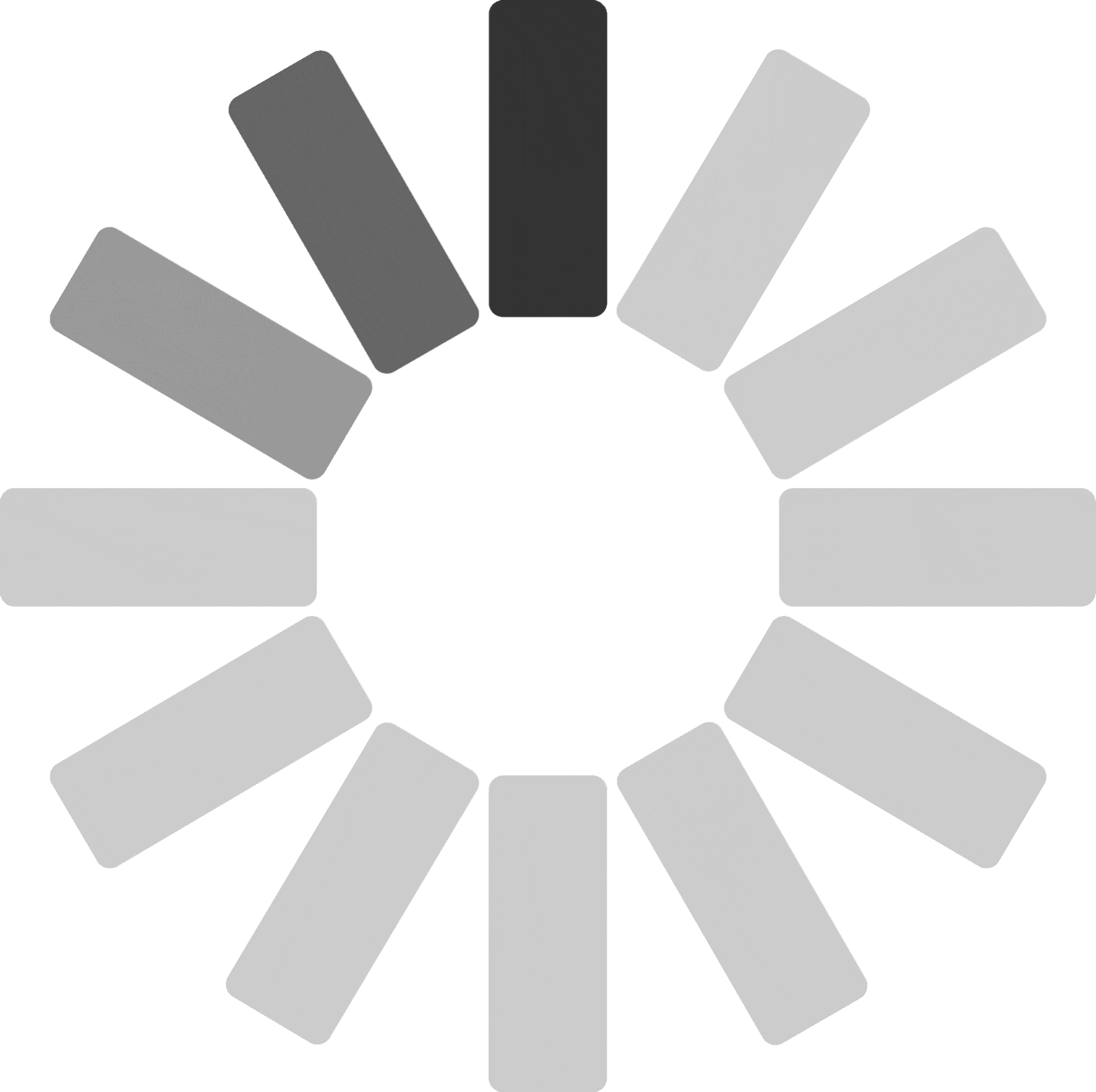Europa, prova a battere questa! Non si era in tempi di Brexit e un orgoglio britannico sano spazzò il continente per più di un anno. Era nata la Jaguar XJ6.
All’urlo, a tutta pagina, della rivista Motor rispose, dall’altra parte dell’oceano, il lamento di Road Test: “Perchè a Detroit non sanno fare auto così?” Ma un po’ dappertutto gli esperti scrissero eulogie. Non pochi azzardarono “la migliore auto del mondo”, la voce corse, clienti vecchi e nuovi si misero in fila. Era nata la XJ6 e con un ruggito aveva mandato in pensione non uno, ma cinque modelli della Casa di Coventry. In molti, nel board, avevano incrociato le dita, perché se è vero che la nuova vettura era incredibilmente più moderna delle sue sorelle, rottamare celebrità come la MK, o la 3.8S sembrava rischioso. Molti affezionati del marchio, negli ultimi anni, si erano orientati sui modelli più piccoli, e poi c’era la 420G, pantagruelica, pensata guardando all’America. Sarebbe bastata un’auto sola a soddisfare palati tanto diversi?
In coda per averla. La risposta venne da sé, poco dopo il Salone di Parigi del 1968. E la lista d’attesa talmente lunga - da Los Angeles alla nostra Italietta - che Bepi Koelliker, importatore ufficiale, dovette pubblicar un annuncio “riparatore” a sue spese. Le grandi berline sembravano vecchie, pesanti, o mancavano improvvisamente di classe. Con l’unica eccezione della Maserati, che però costava il doppio. Le Mercedes sembrarono adatte solo più per il Papa, totalmente poco sexy, nella loro mancanza di curve e rigonfiamenti. La BMW aveva un motore più svelto, era moderna e costruita alla tedesca. Ma dentro sembrava, appunto, un ufficio bavarese. In Francia, come in Italia, mancavano gli avversari. Le americane – come aveva ben scritto il giornalista di mezzo secolo fa – erano indietro...di mezzo secolo. Altro fattore vincente (come già per la E-type, cinque anni prima) fu il prezzo: sul mercato interno 2398 sterline per la XJ 2.8 contro le 3324 di una Mercedes 280 SE e le 3245 di una BMW 2800. La situazione si capovolgeva in Germania, gravata da tasse di importazione altrettanto forti. Mentre il confronto era più equilibrato nei paesi “neutrali”, ma comunque a vantaggio della berlina inglese.
Piacque in ogni aspetto. Così il mondo si innamorò di quest’auto che si riconosceva a colpo d’occhio, che univa la tecnologia a uno stile che, pur rinnovato, sembrava la summa di tutto ciò che piaceva di una Jaguar. C’era il motore XK, glorioso campione a Le Mans, che con un po’ di fatica regalava ancora emozioni. C’era il silenzio frusciante, c’erano le straordinarie sospensioni (derivate dalla E-type), che insieme a una scocca rigidissima davano la tenuta di una sportiva. C’era, sopra tutto, la mano di Sir Lyons, che aveva rifinito quel leggerissimo padiglione, la coda rastremata e raccordata alle piccole luci, le sagome tonde e le proporzioni perfette, sotto ogni profilo. Ultima, ma solo in successione, veniva il colpo d’occhio degli interni. Che era, in realtà, uno dei crucci della concorrenza: i legni quel tanto che servivano, la pelle Connolly profumata, panni e tappeti in tinta, la giusta percentuale di cromature. E, dall’altra parte, una parata di interruttori e quadranti più aeronautici che stradali, che aggiungevano al “castello su ruote” la tecnica di uno Spitfire. Ma il castello era anche solido e sicuro: la paratia antifiamma doppia, la colonna dello sterzo collassabile, i punti nevralgici della carrozzeria ad assorbimento d’urto.
Sei o dodici. Il motore “straight six” 4.2 fu la causa delle rotondità sul cofano (nei prototipi non c’erano, nei modelli di serie furono invece apprezzati). La XJ, però, debuttò con due cilindrate. La versione maggiore, condivisa con la E-Type, ma alimentata da soli due carburatori, e la 2.8. Questa, nonostante un errore di progettazione, che portava al cedimento dei pistoni (e che poi fu corretto), è oggi considerata da alcuni quella con il motore XK più divertente. La verità è però che la XJ6 avrebbe dovuto debuttare con il V12, e l’alternativa del solo 2.8 per la versione meno lussuosa. Ma lo sviluppo del propulsore di 5.3 litri richiese molto più tempo la nuova ammiraglia divenne XJ12 (quella ancora oggi più quotata) solo nel 1972.
Uno stile eccezionale. Forma e sostanza di alto livello contribuirono in egual misura al successo della XJ. È però giusto supporre che fu lo stile a farne un’auto di personalità straordinaria, che affascinava letteralmente il pubblico. Sia quello che poteva permettersela, che quello, molto più numeroso, che riusciva soltanto a guardarla passare. Questo fascino colpi in tutto il mondo, indipendentemente dal gusto nazionale. Quelle linee così armoniche, che sembrano soddisfare le regole auree di proporzione che sono la base del disegno automobilistico, avevano cominciato a evolversi nel 1964. Sir William Lyons, fondatore e presidente della Casa di Coventry, seguiva lo stile di quella che sarebbe stato la sua ultima Jaguar. Il muso fu tratto, come noto, dai modelli 420 e 420G che già avevano svolto con maestria il tema dei quattro fari di diverso diametro, che impostano il cofano e il quarto anteriore. Ma la fiancata e la coda furono tutt’altra musica, con un netto distacco dalle linee molli e un po’ snervate delle berline precedenti. Sir Lyons esplorò vari terreni, prima di approdare, nel 1965 a un risultato pressoché definitivo. E fu un bene che la sua ricognizione rimase in quota, perché alcune delle maquette che sono emerse dagli archivi in anni abbastanza recenti, non avrebbero garantito la fortuna e la longevità della XJ. Essendo, nel ’64, la E-Type il fenomeno del momento, il grande imprenditore-disegnatore si divertì ad abbinare la coda della sportiva ad una carrozzeria tre volumi. Per poi pentirsi e tagliarne via una larga porzione, cominciando ad affinare la poppa della nuova vettura che ha, in effetti, un andamento nautico. Persino i fari anteriori carenati e la presa d’aria ovale furono tentati su un gesso, prima di lasciare il posto ad altre varianti. Almeno una era di gusto piuttosto italiano, con due soli proiettori e un'inedita (per Jaguar) calandra tripartita. Anche i passaruota furono rettificati per modernizzare la geometria della fiancata e mettere in evidenza i grandi penumatici che la Dunlop aveva appositamente progettato per il nuovo modello.
La proposta italiana. È noto che le proporzioni guida della XJ sopravvissero attraverso la più squadrata la J40 del 1986 e la X-300 del ’95. Furono invece perse con la X350 del 2003, che lo stesso Ian Callum, chief designer dal 1999 definì un pasticcio (la trovò, in effetti, quasi ultimata prima del suo incarico). Con l’arrivo della “scuola tedesca” e la attuale X-351, molta gente fatica a riconoscere una XJ da ...qualcos’altro. Ma probabilmente questo è esattamente ciò che il marketing vuole. In questa storia resta però - e non solo per noi italiani - una appendice breve, ma sensazionale. Che avrebbe potuto diventare un nuovo libro. Racconta ciò che lo stile Jaguar del futuro avrebbe potuto essere se, invece della XJ 351, la XE e altri modelli allineati al gusto del momento, i vertici di Coventry avessero guardato, un attimo in più, alla proposta che Bertone aveva azzardato al salone di Ginevra del 2011. A quel concept “Jaguar B99” che univa magistralmente passato e futuro e che il capo supremo Adrian Hallmark si affrettò ad affondare con un “non fa per noi”. Certamente la squadra torinese guidata da Michael Robinson era stata temeraria a pensare di sfidare Ian Callum e il suo nuovo corso. E i tempi per poter suggerire una alternativa, ormai trascorsi. Resta il fatto, che a sette anni dalla sua creazione, la B99, se ascoltata, avrebbe ancora qualcosa da dire.