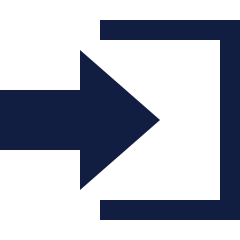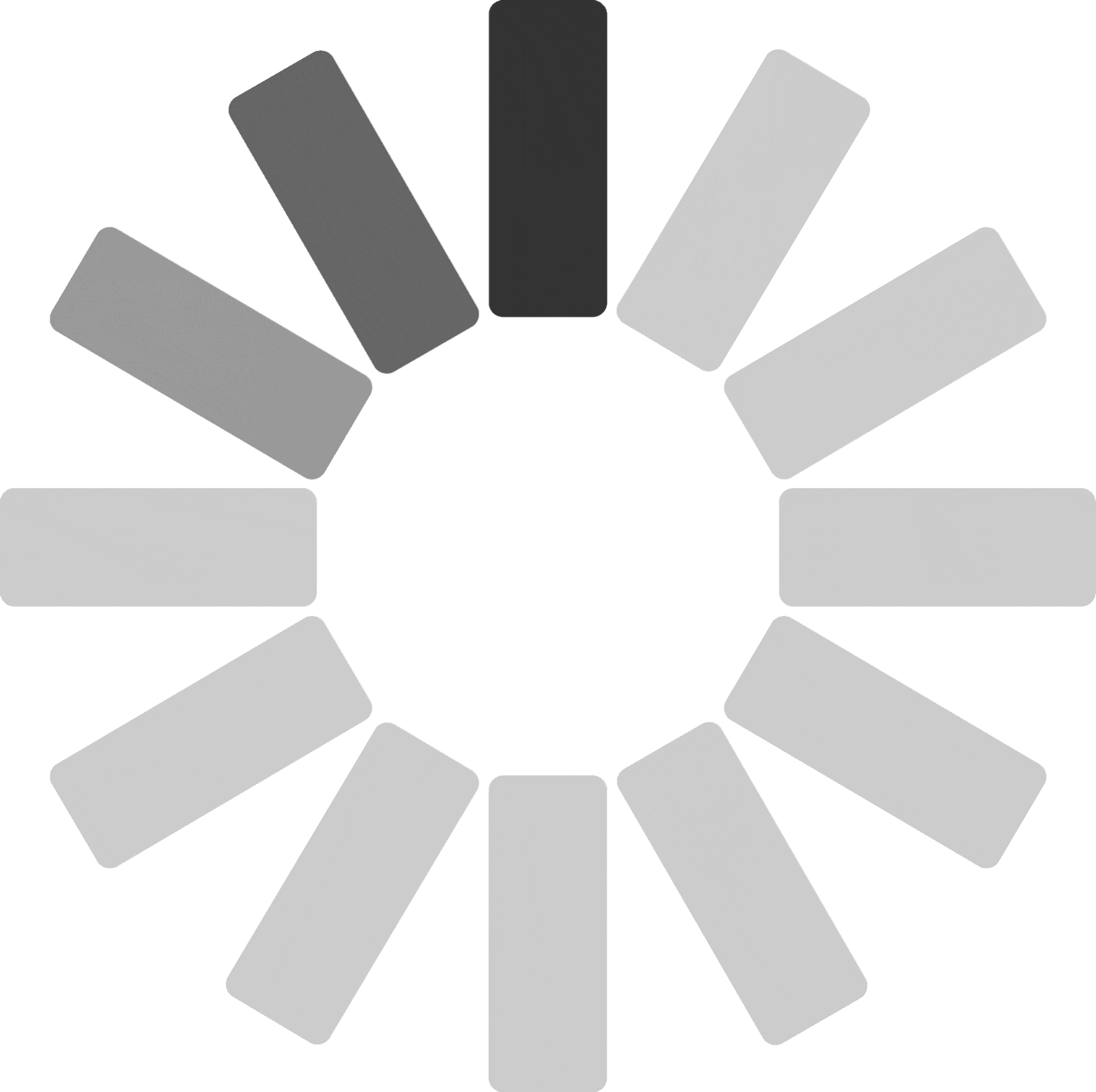Regina o cenerentola? Incompresa o incomprensibile? La 130, ultima vera ammiraglia Fiat, divide ancora gli animi a oltre mezzo secolo dalla sua nascita. Questa tempesta a tutto campo, che coinvolse progettisti, manager e pubblico val la pena di essere riletta. Anche per scoprirne, per bocca dei protagonisti, alcuni gustosi retroscena.
La tempesta di questa settimana durò in realtà tutta una stagione, dalle prime nuvole che già l’offuscavano ancor prima di cominciare, fino ai tremendi rovesci, le cui immagini sono entrate nella storia. Ne fa le spese una strana automobile, la Fiat 130, che in molti di noi oggi guardano con una certa simpatia. Quasi rimpianto. Aveva non pochi difetti, ma anche fascino. Fu, in fondo, l’unica ammiraglia Fiat di cui, dai baby-boomer in poi, si possa avere memoria diretta. E fu veramente una scommessa. Anche se giocata senza molta convinzione. In perfetto stile Fiat.
Le memorie di Giacosa. Nelle suo “I miei quarant’anni di progettazione alla Fiat”, Dante Giacosa dedica ai fatti della 130 pochi, ma illuminanti passaggi. E’ noto che il grande ingegnere avesse un debole per le utilitarie. Ma nel corso della sua carriera si esercitò anche su vetture di classe media. E poi curiosità e meraviglie, come la Cisitalia, la Campagnola, la Fiat a turbina, la 8V e la Dino, senza contare la famiglia delle 1800/2300. Il progetto XC 1/3, però, nato nel 1963 e sbocciato al Salone di Ginevra del ‘69 con il nome 130, non gli destò mai particolare entusiasmo. Cinquant’anni dopo i vertici aziendali, per recarsi in Duomo nel rendere omaggio a Marchionne, sono orgogliosamente scesi da una Jeep. O in quello che vede, tra i dieci modelli Fiat in listino, tre Cinquecento, una Panda, due furgoncini e tre Tipo “world car”. Ecco quindi che camminare lungo cinque metri di sagome e cromature, intravedere pelle e velluti di lino tra i cristalli, ascoltare il gorgoglìo di un 6V di tre litri, tocca al cuore.
Questione di pedigree. La 130, lo abbiamo già detto, non fu un’automobile fortunata. Quando, dopo lunghi studi, venne posteggiata accanto alle varie Mercedes, Jaguar e BMW, in molti si chiesero per quale ragione l’élite dei clienti avrebbe dovuto scegliere una vettura di lusso che aveva il marchio della 500. Giacosa l’aveva avversata fin dalle origini, temendo che drenasse risorse da destinare a progetti vitali. E sentendola aliena alla cultura del marchio. Dopo esserne stato lontano per tutta la fase di ricerca, aveva raccomandato all’ingegner Bono di lanciare la 130 solo quando tecnicamente perfetta. La vide invece debuttare con alcuni vizi, a cominciare da quel motore firmato Lampredi, ma nato male, che consumava un terzo in più della concorrenza e dava un terzo di cavalli in meno. Per non parlare del prezzo, 3.150.000 lire, allineato a quello delle berline più blasonate.
Voluta dai tecnici. Nella lettera al potente ingegnere-amministratore, si leggeva ancora: la perfezione della Mercedes è frutto di generazioni di esperienza, l’auto è diventata eccelsa affinandosi anno dopo anno. Mancava una conclusione del tipo “noi come faremo?”, ma il messaggio era chiaro. Così, anche se, quando fu presentata, molti la definirono una bella automobile (e lo stesso potremmo dire oggi, maestosa nelle proporzioni, italiana e americana insieme, con abbondanza di fregi ma le linee tese, equilibrate), quando si trattò di acquistarla la gente ringraziò e andò a comprare tedesco o inglese. Più che ricordare come era fatta la 130, cosa che molti lettori conoscono perfettamente, è utile contestualizzarla. Pensare che la Fiat che la mise in cantiere non è quella dei manager, ma degli ingegneri. Non è quella del marketing, ma della produzione.
Visione totalitaria. Un impero (terra-mare–cielo, era il motto della Scuola Allievi) abituato ad aver venduto quasi tutto prima ancora di averlo prodotto. Circondato da alte mura, politiche ed economiche, in un regime di semi-monopolistico e di protezionismo doganale. Ricorda Lucio Fiore, allora responsabile del servizio studi e prodotto di corso Marconi, che i dirigenti Fiat con una cultura tecnico-commerciale si contavano sulle dita di una mano. Si può rispondere che per vendere la 128 non servivano. Il problema era costruirne abbastanza. Ma per la 130 le cose erano diverse. E contraddittorie. Da un lato, spiega ancora Fiore, l’ammiraglia fu voluta per provare a ridurre la parentela della marca con le auto da poco. Per dare un bollino di garanzia alle varie 124, 125, che dal ‘69 avrebbero dovuto competere nel Mercato Comune con Peugeot, Renault, Simca, Ford.
Questione di marketing. Ma la grande berlina, aveva detto qualcuno a Torino, avrebbe potuto fare bene anche a chi comprava la 850 o la 500, perché una nuova concorrenza sarebbe arrivata anche dal basso. Dall’altro lato del ragionamento, mancava un’esperienza per dialogare con la clientela di un’ammiraglia. Per convincerla a giocare la scommessa. Negli uffici di comunicazione e anche nelle concessionarie. O forse, anche più in alto. Una prova interessante è il testo dell’annuncio a doppia pagina (per l’epoca costosissimo) con cui partì la campagna pubblicitaria: “La 130 appartiene a una categoria di automobili per le quali una descrizione elogiativa non ha valore. Chi si interessa a una tre litri è un conoscitore (...) Avere la pretesa di influenzarne il giudizio è superfluo.
Cosa resterà? “ Appunto. Il risultato fu che la vettura, con la versione 3.2 che andava anche meglio e una coupé modernissima), vendette 15.000 pezzi nei suoi otto anni di vita. L’ombrello di immagine che si aprì – se si aprì – fu soprattutto quello della televisione, che riprendeva l’invisibile 130 in versione “auto blu”, nel cortile del Quirinale. O, ahimè, all’angolo di via Fani.