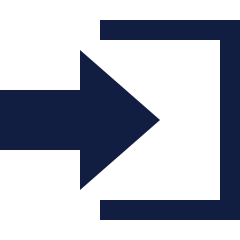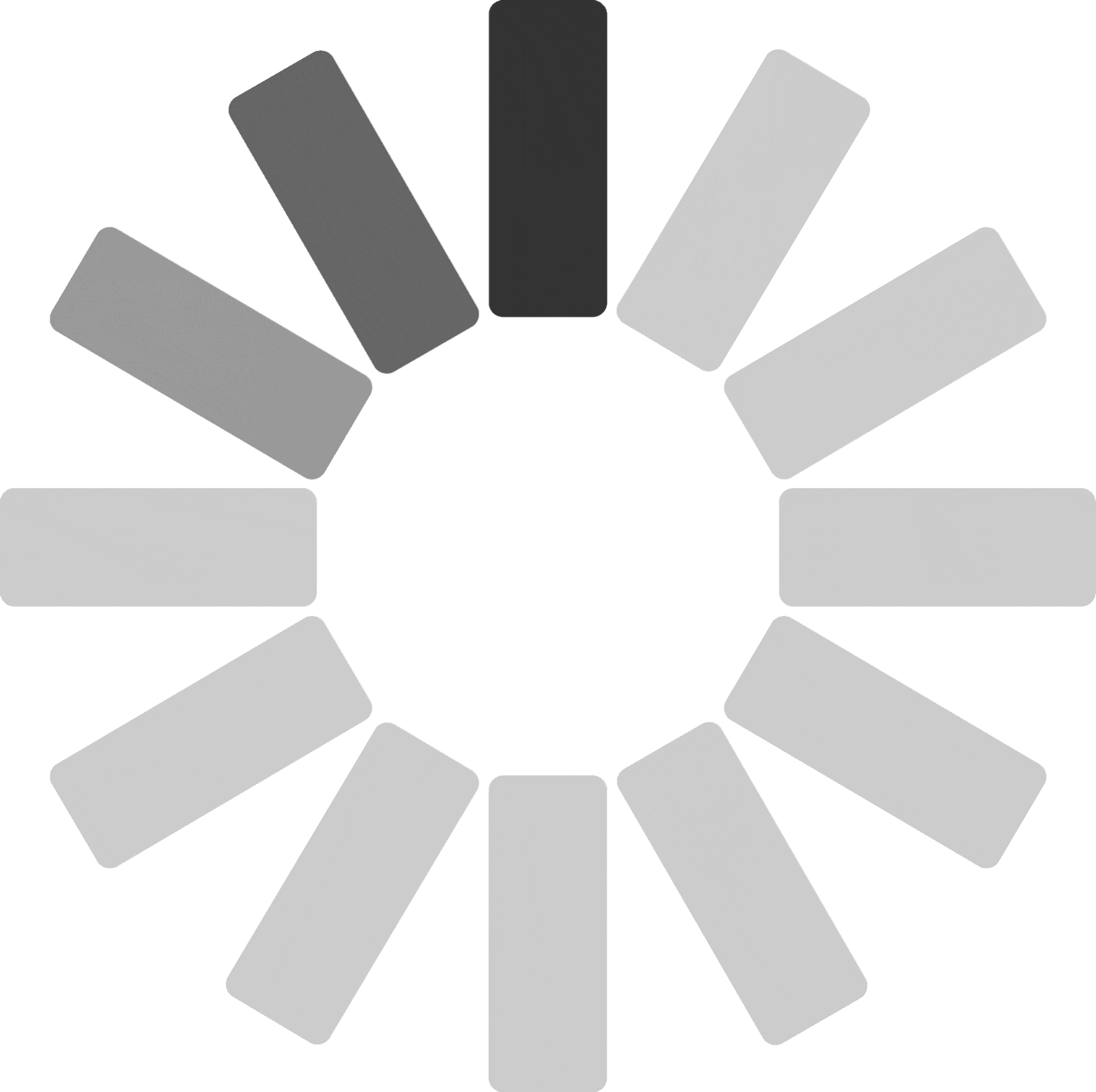Non tutti i giorni dell’Avvento scorrono sereni. In un dicembre di tanti anni fa si scatenò una buriana davvero memorabile nella storia dell’auto: quella che buttò Alejandro De Tomaso fuori dalla Ghia e fece ruzzolare la storica carrozzeria sul viale del tramonto.
La sensazione era nell’aria da un po’ di tempo. La fune sempre in tensione, il contraddire tutto e tutti per poi cambiare maschera, il potere seduttivo e brutale avrebbero, prima o poi, disfatto l’azienda.
Alla Ford su De Tomaso si raccontavano barzellette, anche se lui era amico di Lee Iacocca e Henry Ford jr. aveva una moglie italiana. Gli ispettori tornavano dalle visite a Modena con più dubbi che certezze e un controller mandato da Detroit, il silenzioso mr. Head, spediva rapporti al veleno sulla gestione allegra della Ghia.
Come potevano allora fidarsi, del caballero argentino, i cultori del marketing, i padri della pianificazione, i figli del lavoro di squadra? Quelli che vivevano nella metropoli dell’automobile, a seimila chilometri di distanza? E infatti un giorno smisero di fidarsi.
Rapporto incrinato. Nel caso specifico della Ghia, il conflitto ideologico tra il gigante di Detroit e l’enfant terrible di Torino era arrivato al paradosso. Tre prototipi italiani, uno dopo l’altro, erano stati rifiutati perché non rispettavano i requisiti-base. Più che non rispettarlo, le proposte della Ghia sovvertivano il briefing perché – e in questo De Tomaso aveva stra-ragione – le specifiche erano vecchie, i concetti decrepiti, il gusto generale pessimo. Ma era ciò che gli americani, prigionieri di una cultura isolata, con le fabbriche obsolete, i budget blindati, la stasi progettuale e le onniscienti ricerche di mercato erano in grado di chiedere. E fu continuando a chiedere questo che spalancarono il loro immenso mercato all’automobile giapponese.
La tempesta. Restando nella piccola Torino, De Tomaso stava perdendo interesse nell’avventura con la Ford. All’avventura di una boutique romana e ai progetti nell’arredamento, si aggiunse il ben più intrigante affare della Benelli. Intanto i prototipi di ricerca richiesti dall’America erano sempre meno, e quelli che partivano venivano realizzati senza grandi aspettative. Quando sparivano nella stiva dell’aereo che da Caselle li traghettava a Detroit, era per sempre.
Nel mezzo di questa bonaccia, squassata, ogni tanto, da un fulmine, andò in scena il grande bluff della X1/9 fotocopiata al Salone di Torino. E’ una storia che vi abbiamo già raccontato e il cui senso di resta ad oggi sconosciuto. Qualcuno, negli anni, è arrivato a pensare che fosse uno scandalo intenzionale, creato ad arte dall’argentino per essere cacciato profumatamente dalla Ford, fare cassa per la Benelli e poter volgere altrove lo sguardo. Resta il fatto che un anno dopo, De Tomaso, non era più il patron della Ghia.
Mentalità differente. La Ghia era, da un punto di vista societario, un ramoscello della Ford. Ma a dispetto dei pacchetti di azioni, non solo non era “posseduta”, ma nemmeno controllata per davvero, visto lo spirito libero di De Tomaso. L’uscita di scena del presidente non assomigliò, quindi, a nulla di americano. A Deaborn i passaggi di consegne, anche al più alto livello, si svolgevano secondo le regole del “politically correct”: poche chiacchiere alla caffetteria, strette di mano, auguri di successo. Anche se il manager in partenza stava per prendere le redini del più agguerrito concorrente.
A Torino, invece, l’atmosfera era shakespeariana. Il boss, quando c’era, si aggirava come una fiera braccata. Le imprecazioni volavano, le porte sbattevano, le segretarie vagavano tra ordini e contrordini, i telefoni suonavano tutto il giorno, i telex anche di notte. Nessuno ufficialmente, sapeva qualcosa. Ma sembrava che De Tomaso ci tenesse a distribuire, con paterna misura e a ciascuno dei suoi sottoposti, una parte del trauma psichico, di rabbia e di stress che gravava sulle sue spalle.
Clima teso. Tom Tjaarda, allora direttore dello stile, fu invitato a sloggiare dall’ufficio senza particolari spiegazioni. Il suo tecnigrafo andò ad aggiungersi agli altri, nello stanzone di mille metri quadri che, dai tempi di Segre, avevano funzionato da mensa, deposito, archivio e spazio di modellazione. E che adesso raggruppava, in un disinfettato ma anonimo open-space, tutti i figurinisti. Finalmente la voce che De Tomaso stava per lasciare la Ghia diventò, almeno in azienda, un fatto acquisito. Ma senza dettagli sui tempi, i modi e i postumi di un’uscita che – dato il personaggio - avrebbe aperto non un vuoto, ma uno squarcio. Uno ad uno i collaboratori furono chiamati nella stanza-museo del presidente. Ci rimanevano mezz’ora e uscivano un po’ pallidi.
Senza smancerie. Come se il clima non bastasse, scoppiò un’agitazione tra gli operai. Un braccio di ferro salariale non diverso da quelli di centinaia di altre aziende. Ma che sommato alla sfida interna alla Ghia e al fatto che niente di simile si era mai visto nel suo piccolo ambiente, turbò gli animi. Mentre ci si scambiavano i commiati gli operai percuotevano cancelli e palizzate con le spranghe di ferro. Le bandiere rosse sventolavano, i fischietti assordavano, gli impiegati, i dirigenti e in particolare Mr. Head - il burocrate americano mandato da Detroit - si guardavano attorno non senza preoccupazione.
Una settimana dopo De Tomaso prese definitivamente commiato. Le persone a cui teneva erano già state salutate e omaggiate privatamente, non vi furono discorsi. Lui si preoccupò soprattutto di far smontare ciò che di suo – o che riteneva suo – aveva accumulato negli anni alla Ghia. C’era un intero garage di prototipi, celebri o dimenticati e persino una Ford T del 1920, che il capo magazzino provò flebilmente a difendere, perché “era lì dai tempi di monsiù Segre”. Tutto, lentamente fu risucchiato, spolverato, portato nei cortili dove attendevano le bisarche. La prima Ghibli, il prototipo in gesso dalla Pantera, la sconosciuta Vanessa, la piccola Rowan sperimentale a batteria, tutta corrosa dall’acido.
L’impresa Benelli. Poi, sotto i primi fiocchi di neve, arrivarono i traslocatori. Insieme al loro camion ce n’era uno con la scritta Benelli sul telone. Un altro segno dei tempi che cambiavano. Ingurgitarono di tutto: i salotti Luigi XVI e le librerie inglesi, due specchi veneziani e una raccolta di porcellane di Capodomonte, con le tazzine in cui i re borbonici sorbivano il gelato fatto con le nevi dell’Etna (De Tomaso lo raccontava sempre agli americani). Quindi toccò alla “galleria d’arte”, decine di dipinti antichi e moderni, da imballare uno alla volta, in cartone leggero. E le casse di libri e giornali, a centinaia, anch’esse destinate ai nuovi uffici di Pesaro. Sembrava, nel sollievo generale, che tutto fosse partito, anche se il vuoto che si apriva ala Ghia era davvero fisico.
Ma ci fu ancora un colpo di tuono. “Chi ha rubato i miei fucili?” urlava De Tomaso da una suite dell’Hotel Canalgrande. La notizia dell’ammanco lo aveva raggiunto malato, nel letto da cui stava tenendo una conferenza stampa telefonica. E la domanda era ben posta perché il giorno dopo – la vigilia di Natale - un ultimo carico, degli strani involti oblunghi ricomparsi chissà dove durante la notte, lasciò Torino alla volta di Modena.